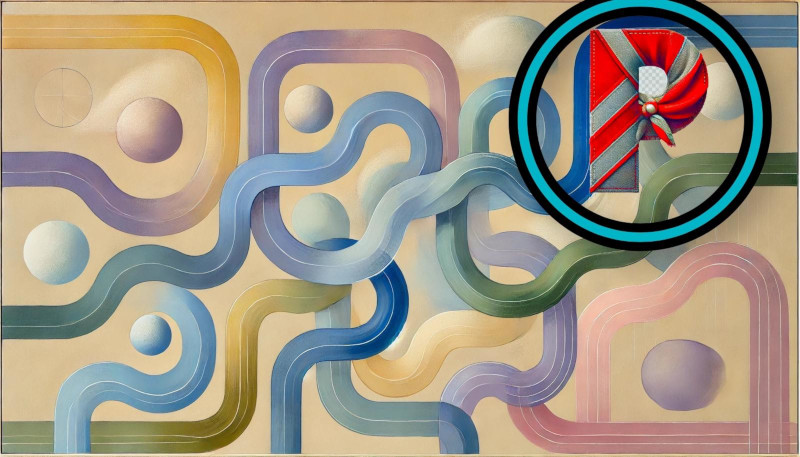
P come pazienza
Che lingua “parlano” i missionari? Il loro è un alfabeto di misericordia, con lettere che ridanno vita alle parole e generano opere
“Uvumilie, padiri. Pole pole vitaanza kuendelea bien (pazienza, padre, piano piano le cose cominceranno ad andare bene”.
E’ quello che mi diceva un amico, un anziano di nome Masongezi. Era un tipo originale, uno dei collaboratori della parrocchia di Baraka, nel Sud Kivu in Congo RDC.
Mi aveva accolto all’inizio del 1984, quando ero arrivato e gli confidavo le mie difficoltà nell’inserirmi in un ambiente nuovo.
Anche lui mi raccontava le sue storie di tanti anni passati, quando nel 1964 e 1967 c’era stata la ribellione in quelle zone e alcuni missionari erano stati uccisi. Ma il loro sacrificio aveva prodotto frutti che ora noi vedevamo con i nostri occhi.
Pazienza, è la parola che viene usata spesso di fronte alle difficoltà, ma purtroppo o per fortuna, non si trova al mercato. Bisogna cercarla dentro di noi e farla crescere ogni giorno.
Qualche volta viene voglia di perderla (ma l’abbiamo mai trovata?) e allora non si sta bene.
L’unica cosa è sapere ricominciare ogni giorno.
Masongezi mi raccontava la difficoltà che avevano i primi missionari nel parlare la lingua, nell’adattarsi al cibo e al modo di vivere della gente.
Lui, insieme ad altri, se ne era accorto e così decisero di dare loro una mano, come lui stava facendo adesso con me. Era un tipo speciale. Durante i giorni di festa era il primo a iniziare le danze. Era un Mbembe, un tipo tosto, e mettendosi in mezzo, muovendo le spalle, dava il via e tutti si univano a lui.
E, come per incanto, le preoccupazioni volavano via, al di là del lago. La gioia si impadroniva di ogni persona che si sentiva unita a coloro che li avevano preceduti. Era qualcosa di speciale e veniva voglia di unirsi a loro.
Qualche volta ci ho provato. Nessuno ti criticava. Anzi, erano contenti che anche tu cominciavi a sentirti a casa tua in mezzo a loro.
Poi la pazienza dovevi esercitarla, capirla, quando chiedevi loro qualcosa da fare e, da “bravo” europeo, ti aspettavi dei risultati subito. Invece, quando venivano da te e chiedevi se erano riusciti a fare quella cosa che avevi chiesto, ti rispondevano: “Univumilie, padiri. Nilisahau. Lakini, usiogope, nitafanya kesho (perdonami, padre. Non aver paura. La farò domani”.
E così andavano le cose e ti ci abituavi al loro modo di vivere il tempo, che è per le persone e non le persone per il tempo.
Poi, quando dovevi partire per un viaggio, in auto o con il battellino, e avevi dato loro l’orario di partire, vedevi che arrivavano con calma. Allora ti veniva voglia di dire qualcosa. Ma la risposta ti bloccava subito.
“Padiri, nilikuwa na maneno, na problème nyumbani. Sikuweza kufanya mbio. Unihurumie (padre, avevo dei problemi a casa. Non ho potuto fare in fretta. Perdonami)”. Te lo dicevamo con un sorriso e tu eri sconfitto.
Così quando arrivavano in ritardo alla messa, eppure avevano l’orologio al polso. Mi veniva da chiedere a cosa serviva, se poi non lo guardavano.
“Ni mapambo” (è un ornamento). E tu cominciavi a cambiare mentalità, cominciavi a capire che il mondo non va sempre come vuoi tu e che se volevi vivere insieme con loro, dovevi cominciare ad accorgerti che anche loro sono delle persone, anche se hanno dei ritmi diversi.
E questo ti aiutava a stare meglio. Non è che poi anch’io arrivavo in ritardo. Normalmente cercavo di arrivare in tempo.
Ma occupavo il tempo dell’attesa per parlare con la gente, per interessarmi ai loro problemi, insomma per far vedere loro che non
ero uno che era venuto a fare i propri interessi, ma per stare insieme con loro.
Allora, cominciavi a scoprire tante cose che loro ti confidavano perché vedevano che potevano avere fiducia in te. Bastava poco per
capirlo, per togliere la “kitchwa nguvu”(la testa dura) e “kuwa na moyo ya kupokea”(e avere un cuore che accoglie).
Fonte

